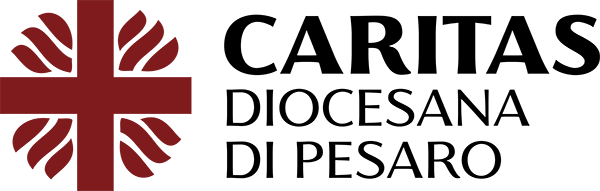Una notte di traghetto salpando da Ancona e attraccando a Spalato, circa tre ore di pullman, con qualche pausa caffè ed eccoci arrivati.
Se partiamo da qui, da Padova, la strada è ancora più breve: solo 6 ore di macchina e qualche attesa in dogana.
Questi sono i modi di percorrere i pochi chilometri che ci separano da Bihać, città bosniaca al confine con la Croazia.
Ho imparato a conoscere Bihać quattro anni fa, crocevia della rotta balcanica e luogo di passaggio per chi cerca, in Europa, una vita migliore. È una città fatta d’incontri, di storie e di speranza, ma è anche un posto di rabbia, di senso di ingiustizia e di vergogna. Vergogna; sì, perché a volte mi vergogno di appartenere a quella che è la “parte giusta” del mondo, che poi così giusta non è. Quella parte che ti consente di fare ciò che vuoi, in piena libertà, ma lo nega ad altri, costruendo barriere in nome di un confine che diventa più importante dell’essere umano.
Allo stesso tempo sono felice ed orgogliosa di fare sentire la mia voce, di dimostrare che c’è anche un’altra Europa, che crede nei diritti umani e nella necessità che questi siano concessi a tutti.
In questo viaggio sono entrata, per la prima volta, a Lipa. Ma dove si trova Lipa? Torniamo un momento a Bihać, la città di cui vi ho raccontato all’inizio. Bene, da lì prendiamo il nostro pulmino e facciamo altri 30 minuti di strada: i primi 15 scorrevoli, i restanti lungo un sentiero pieno di buche e sassi dove il nostro pulmino ci fa ballare.
Qua troviamo Lipa, lontano dalla città, lontano dalla vista di tutti: intorno solo montagna. Scesi dal pulmino ci si apre davanti una distesa di container. “Hello my friend”… “How are you today?”
Salutiamo tutti con il nostro miglior sorriso sperando di alleggerire i chilometri alle spalle e quelli davanti. Eccoli lì i nostri amici; accovacciati sull’asfalto, appoggiati ai container, con quello sguardo. Quello sguardo è la costante di ogni viaggio, uno sguardo senza tempo, senza riferimenti, fatto di attesa mista a speranza. Vorrei poterlo catturare per portarlo con me, per mostrare a tutti che vite possano esistere fuori dalle nostre case. Invece, talvolta, faccio perfino fatica a sostenerlo.
Mentre riordino il materiale per le attività mi sento agitata, inadatta, inadeguata. Come posso io, giovane ragazza europea, con una bella casa, un lavoro e ad un passo dalla laurea, proporre loro di giocare? Di fare teatro, disegnare, cantare. Come possono aver voglia di divertirsi, con quel peso sulle spalle?
Poi arrivano al Social caffè e il tempo inizia a scorrere di nuovo: giochiamo a palla, corriamo, pitturiamo. In poco tempo le mie insicurezze scompaiono: mi diverto con loro, ma non come quando fai finta di stare al gioco perché devi intrattenere qualcuno, io mi diverto in modo autentico. Non sono un’animatrice, sono una partecipante.
Mi scopro una brava pittrice e una pessima ballerina, imparo come si gioca a “scacchi Afghani” anche se perdo sempre, imparo a fare braccialetti e litigo con una macchina da cucire. Imparo che il gioco non è solo un gioco, che può tenerti vivo e renderti umano. Il gioco può accorciare le distanze e aprire la porta al racconto e alla comunicazione. Così io ascolto, ascolto le voci di chi desidera raccontarsi e arrivo alla sera con il cuore pieno, ma un bagaglio pesante.
Sono tante le domande che affollano la mia mente. Come può la nostra Europa, culla dei diritti civili, macchiarsi di tale orrore? E noi, in quanto suoi cittadini, come possiamo esserne complici? Siamo complici, sì; perché una parte di responsabilità è anche nostra. Siamo responsabili delle loro storie.
Siamo responsabili della storia di Rashid, partito due anni fa dall’Afghanistan per dare ai suoi fratelli la possibilità di studiare, è partito con il desiderio di fare l’università, di guadagnarsi quel diritto allo studio che ti permette di diventare chi vuoi.
Alì vuole fare il Biologo, l’entomologo per esattezza, e mentre mi chiede come funzionano le tasse universitarie in Europa nella speranza di poterle, un giorno, pagare pur mantenendo i suoi fratelli, mentre mi chiede di spiegargli l’anatomia medica, viene respinto 12 volte tra Grecia e Bulgaria e ben 4 volte al confine croato.
Siamo responsabili del racconto di Mas, originario del Burundi, designer per interni con il sogno di lavorare a Milano. Scappato dalla sua città per l’estremo razzismo che la divorava. “I want to go to Europe, because in Europe there are Human right”, mi dice mentre mi mostra la cicatrice sulla faccia del fratello. Hanno già provato 6 volte e sono stati respinti e derubati dalla polizia croata. Mas mi chiede quante lingue io sappia parlare. Rispondo che oltre l’italiano parlo l’inglese.” Are you a doctor and speak only one language?” mi dice stupito, e aggiunge “you also speak it badly!” Un po’ mi vergogno, ma sorrido; il mio inglese è davvero pessimo.
Siamo responsabili delle vite di Mustafa, Ahmet, due fratelli pakistani di 17 e 18 anni che scrivono su un foglio “la famiglia è tutto”, quella famiglia da cui sono stati ritenuti i più forti per sostenere il viaggio, di İbrahim che di anni ne avrà circa 14, anche se lui dice di averne 18. Siamo responsabili di chi sogna di fare l’avvocato, chi il calciatore, chi sogna solo di avere un futuro per aiutare la propria famiglia.
Io ascolto e mi pervade un senso d’impotenza e di gratitudine per avermi regalato un frammento così prezioso della loro storia. Ascolto e non capisco come l’essere umano possa far questo ad un suo simile, mi dico che custodirò questo racconto al sicuro, ma allo stesso tempo vorrei che tutti lo sentissero, vorrei che tutti capissero. Non posso fare altro che ringraziarli e salutali.
“Good luck my friend, see you in Europe”.
Oggi sono tornata e come al solito non riesco a tradurre in parole quello che mi porto dentro. Oggi, sono nella mia amata casa con il mio gatto che fa le fusa, e penso a quanto quei dieci giorni mi abbiano cambiata: ripenso alla gentilezza dei loro modi, a tutti i “come stai?” rivolti a noi con interesse, ai sorrisi e alla paradossale leggerezza dei nostri pomeriggi che sembrava quasi sbeffeggiare quel loro futuro incerto e pauroso. Allo stesso tempo penso a quanto sia forte il senso di ingiustizia, a quanta rabbia io provi. Così decido di non farla cadere nel vuoto, ma di raccoglierla e gridare a gran voce la mia esperienza; cercare le parole che non trovo, ma provarci lo stesso, provare a raccontare.
Testimonio, chiedo attenzione, chiedo informazione, chiedo indignazione e rabbia per queste storie. Così porto avanti il mio senso di giustizia personale e spero di fare la mia piccola parte affinché domani non ci siano più, in posti come Lipa, Rashid, Mas, Mustafa, Ahmet e Ibrahim, e che loro possano essere ovunque nel mondo a coltivare i propri sogni.
Elisa